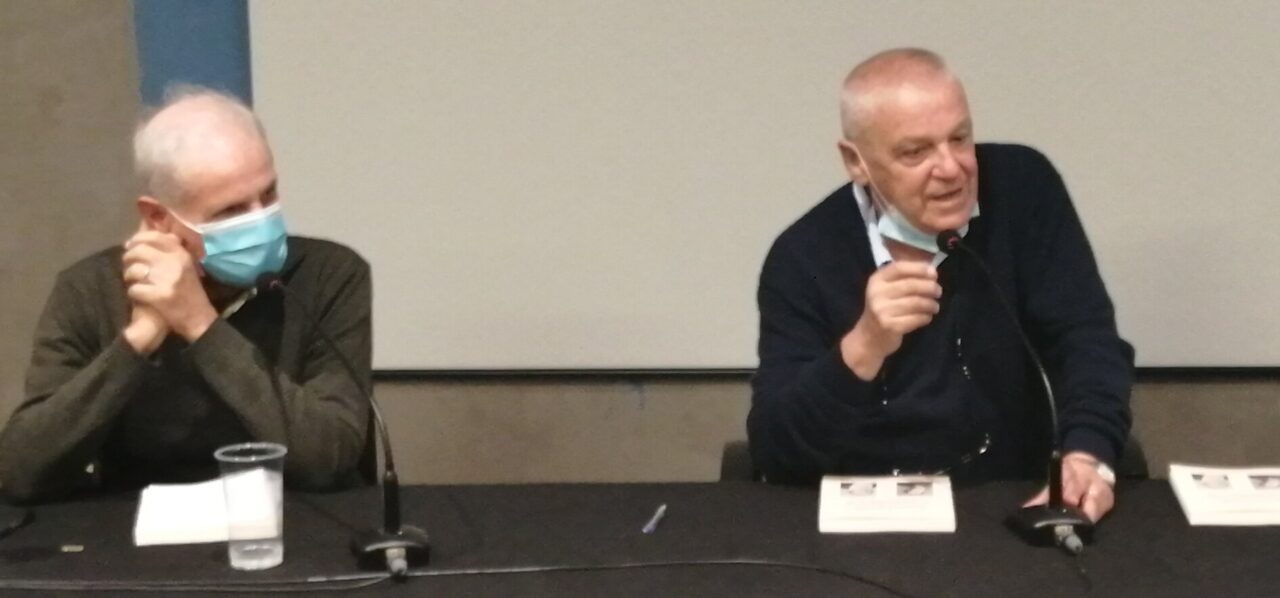Ritorno ancora una volta, al tempo lontano dell’infanzia, dell’adolescenza, dei primi amori, degli studi, del lavoro, dei tanti volti, dei loro nomi e delle loro “scurmagne” (i «suranùm», i soprannomi) scolpite nella pietra viva della memoria. Le pagine sono quelle, bellissime, tra testo (in italiano ma soprattutto in trevigliese, a brani ampi e suggestivi) e fotografie d’epoca (decine), della terza fatica letteraria ed editoriale di Arturo Prandina, trevigliese doc, che già nel 2013 e nel 2016 aveva dato alle stampe due prime raccolte di ricordi e divagazioni sulla Treviglio che fu.
Il terzo volume di Prandina
I due precedenti volumi, e anche quest’ultimo (in parte), erano stati preceduti dalla pubblicazione sul settimanale “Il Popolo cattolico”, di racconti “a memoria” sotto forma di articoli da leggere e rileggere. Una memoria personale che assurge a memoria collettiva nell’eco dei tanti, tantissimi che ascoltando le parole del narratore sentono rinascere dentro sé quegli stessi umori, quei proverbi passati di bocca in bocca, questi frammenti di poesia imparata tra i banchi di scuola. Allora, leggendo un brano, guardando una foto, la mente spazia in quel deposito di ricordi che ciascuno di noi ha da qualche parte e riemergono magicamente dalla nebbia del passato un sorriso, un movimento tipico, una battuta, un episodio comune. Il volume testimonia i ricordi indelebili della madre, «Mariù» (Mariuccia Pilotta), del padre «’Ngelino» (Angelino Prandina), della zia Rusèta (Rosetta Prandina, morta in giovane età all’inizio degli anni cinquanta), del fratello Gianmario, della tabaccheria di famiglia, della scuola (il «Facchetti») degli amici di famiglia, dell’oratorio, del prete, don Guido Crippa, di quei viaggi alla colonia elioterapica (ironicamente, ma neppure troppo, detta «penale»), con il loro carico di emozioni, vibranti di commozione, ma anche di ironie, di osservazioni minute, di sottolineature in dialetto (la «lingua delle voci» delle tante province italiane) che sanno sempre di intelligenza ed espressività, e di sguardi sulle trasformazioni, quelle piccole e quelle grandi. Erano gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, e da paese rurale Treviglio stava diventando una città di piccola industria e di servizi.
«Non si può andare “alla ricerca del tempo perduto” come scriveva Marcel Proust, ma si può sempre sognarlo, ricordarlo e, con malcelata malinconia rievocarlo, cumè ma par sò ‘n bal a fa mé», ha scritto Prandina.
Leggi di più sul Giornale di Treviglio in edicola oppure QUI